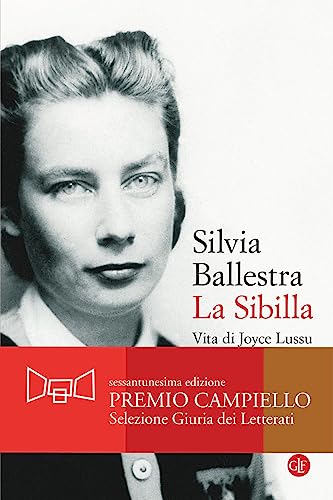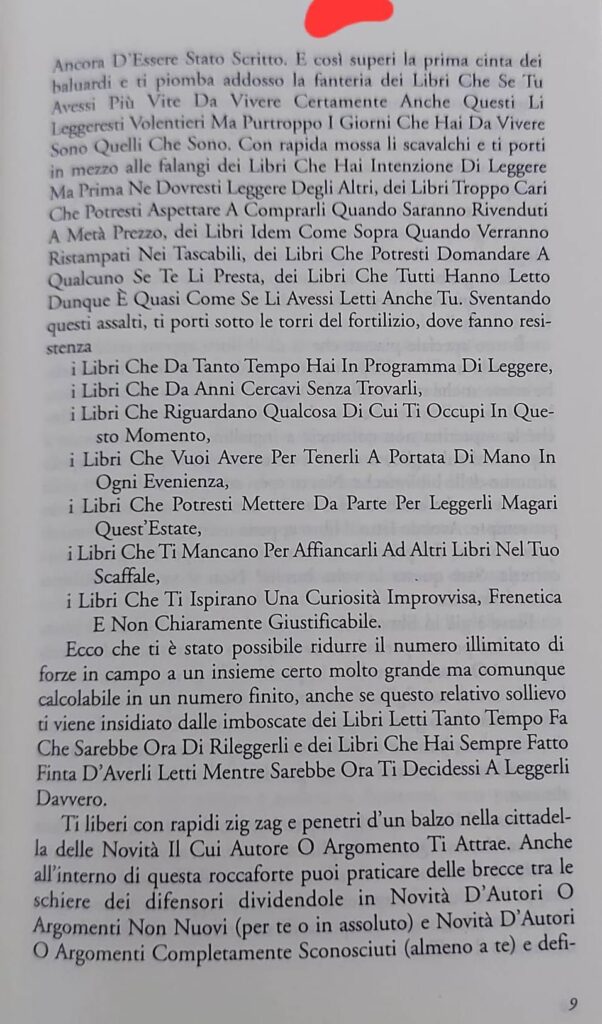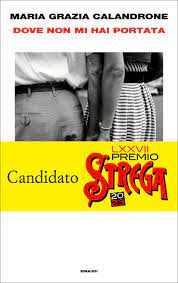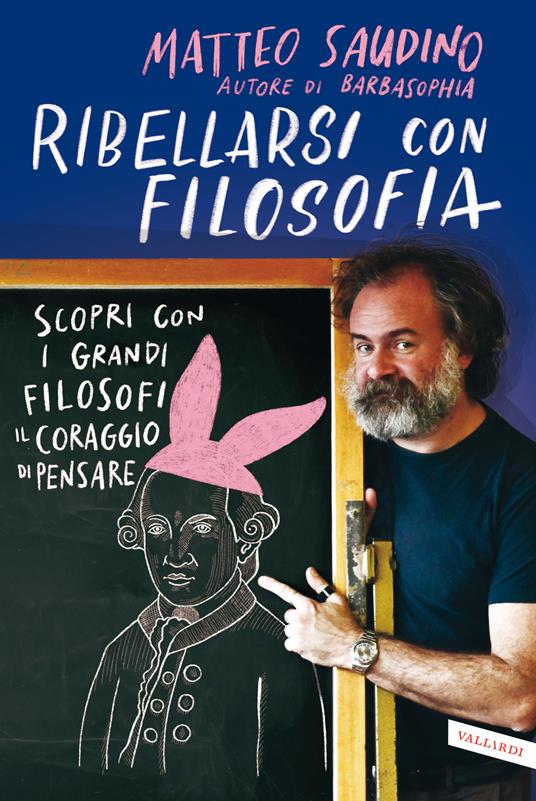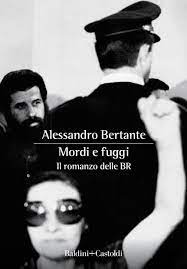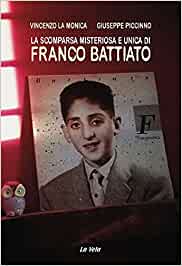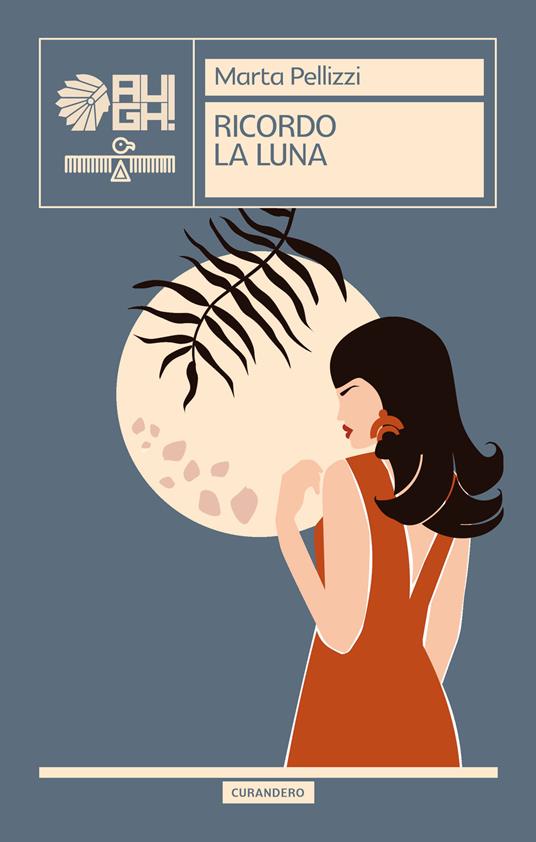
Una mano accarezzò l’indice destro per tutta la sua lunghezza, soffermandosi sulla punta. La dolcezza del tocco mi fece brillare gli occhi, mamma era lì. Non riuscii a compiere un discorso sensato, ripetei una decina di volte «mamma». Udii borbottare disperatamente una tragica frase e poi cadde il silenzio. (pag. 23)
Marta si stava preparando alla maturità (il momento più intenso per la vita di un giovane, momento di scelte determinanti per il futuro, di speranze e sogni) quando improvvisamente si risveglia in un letto della terapia intensiva e prende atto del cambiamento che subirà la sua vita. Fermata da una malattia terribile alla quale non si arrenderà, troverà la determinazione e il coraggio di prendere in mano la propria vita e di ricostruirla, anche quando la lotta si fa impari.
“Ricordo la luna” è la storia di questa lotta. È la storia del coraggio di una ragazza e del difficile cammino nel suo farsi donna. È la storia di donne forti (mamma Anna, zia Franca…) che si sostengono per proseguire, senza mai arrendersi. È la storia di legami familiari che hanno radici lontane, ma forti e vitali, tanto da trasmettere l’energia necessaria ad andare avanti. È la storia di una malattia, ma anche della burocrazia disumana che assume le sembianze di impiegati senza anima, incapaci di vedere, ma abilissimi nel seminare ingiustizie.
Con la forza che la caratterizza, già affinata contro il male, Marta si impegnerà a combattere per il riconoscimento dei propri diritti calpestati da burocrati freddi e indifferenti, pronti ad umiliare, aggiungendo dolore al dolore. Ma, come scoprirete leggendo il romanzo, Marta non è una ragazza che si arrende: anche nei momenti più bui, riesce, metabolizzato lo sconforto, a reagire contando sulle proprie risorse e sulle proprie competenze:
“Avevo un enorme potere: raccontare agli altri la vicenda. Raccontarla avrebbe fatto bene”.
Nasce così il diario online che libera Marta dall’isolamento imposto dal Covid e la spinge alla condivisione della propria esperienza e della propria vita, tanto da divenire un simbolo, fino a vincere la lotta contro un sistema cieco e irrazionale.
La scelta di un diario online non è stata casuale: infatti, Marta, nonostante i limiti fisici imposti dalla malattia, si è laureata a Ferrara in Scienze e tecnologie della comunicazione, è diventata una social media manager. Di fatto, svolge la professione di consulente e formatrice freelance con attività online. Anche il romanzo è nato da questa sua esperienza ed è stato sostenuto dalla comunità di Twitter sulla quale ha tantissimi follower, così come nella sua pagina Instagram dove di sé scrive: “Ascolto libri, combatto ingiustizie e creo rose di carta pesta”.