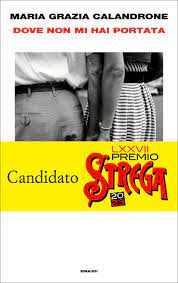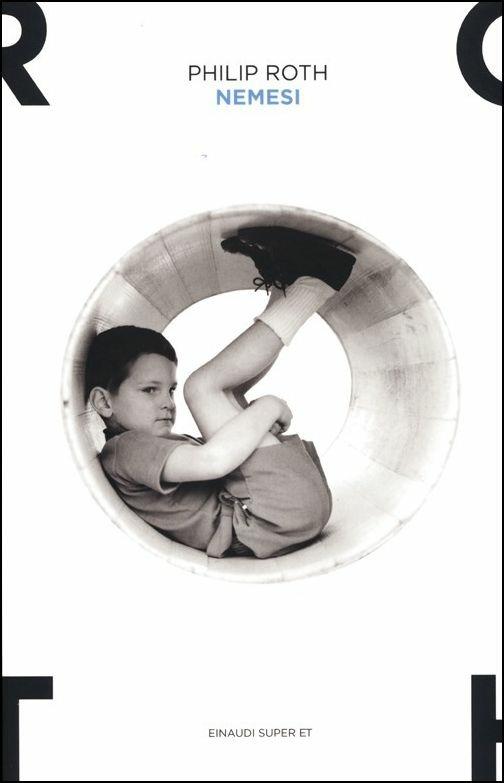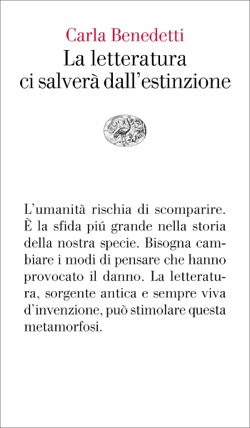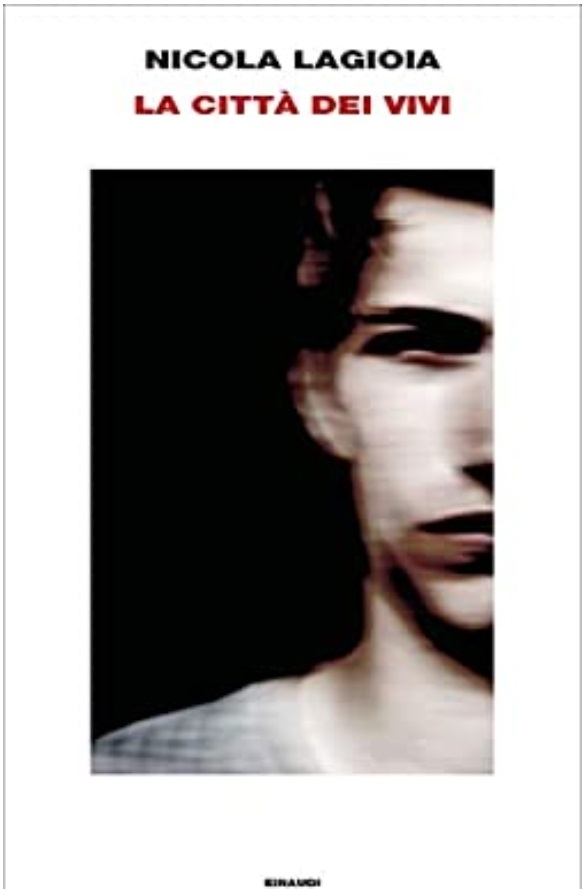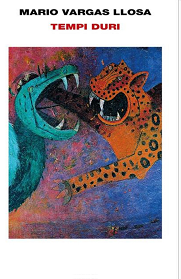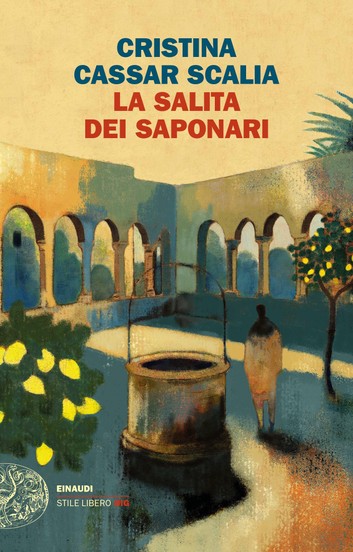“La nostra speranza, credo, è che quel giorno, ora lontano, in cui avranno scontato tutta la pena, tornerà nelle loro mani questa chiave, e dagli archivi spalancati voleranno fogli bianchi senza più inchiostro sopra, immacolati, come il bucato steso sulle terrazze”

Ci sono romanzi che fai fatica a leggere, che saresti tentata di chiudere e andare oltre, ma che ti impediscono di farlo, costringendoti a proseguire, fino all’ultima pagina, magari sperando in un evento improvviso capace di sciogliere il grumo di dolore e offrire un lieto fine. Sofferto, ma comunque lieto.
“Almarina” rientra senza dubbio tra questa tipologia di romanzi.
Si tratta di “romanzi disturbanti”, come sono solita definire quelle narrazioni capaci di rivelarti un mondo che sai esistere, ma comunque lontano e di cui difficilmente entreresti a fare parte. Valeria Parrella, invece, ti conduce in quella realtà a te estranea con forza impietosa, rivelandoti la precarietà comune a tutti noi umani, insieme a Elisabetta Maiorano, la protagonista del romanzo.
Una donna non più giovane che ha sperimentato sulla propria pelle quella precarietà, ed è capace di individuarla e comprenderla nelle persone intorno a sé, riuscendo a darle un nome e a farsene carico. Insegnante di Matematica, svolge la propria professione a Nisida, nel carcere minorile ospitato dall’omonima isola nel Golfo di Napoli, di fronte a Posillipo il cui legame è narrato dal mito.
Nisida infatti prende il nome dalla ninfa che rifiutando l’amore del giovane Posillipo lo costrinse a morire in mare. La crudeltà della ninfa sembra dare forma al carcere minorile che si innalza come un ossimoro in un posto incantevole, quasi un locus amenus, ma di fatto luogo di privazioni.
Valeria Parrella conosce bene l’organizzazione del carcere minorile per avervi svolto dei laboratori di scrittura creativa, come emerge dalla lettura del romanzo, ma anche per il proprio impegno a favore dei diritti dei detenuti.
Tra i ragazzi reclusi arriva Almarina, adolescente romena, giunta in Italia assieme al fratellino per sfuggire alla violenza del padre che, dopo averla abusata, l’ha quasi uccisa di botte. La ragazza porta addosso, e nell’anima, i segni della violenza paterna, ma anche degli abusi di altri uomini, incontrati durante il viaggio. Tra Elisabetta, incapace di rimanere indifferente di fronte al vissuto della ragazza, e Almarina nasce un legame profondo che si concretizza nella scoperta di un comune sentire, in una quotidianità, appena abbozzata e subito interrotta. Un legame che la separazione non riesce a spezzare e spingerà Elisabetta a tentare di scrivere una nuova pagina per sé e Almarina.
Sarà possibile? La Parrella ci regalerà il lieto fine come nelle fiabe?
Rispondo subito alle domande: “Almarina” non è una fiaba e non si conclude con “vissero felici e contenti”, il lettore, però, potrà immaginare la conclusione che sente più congeniale. Per quanto mi riguarda, io la mia non l’ho ancora raffigurata. Eppure ci penso già da qualche giorno.