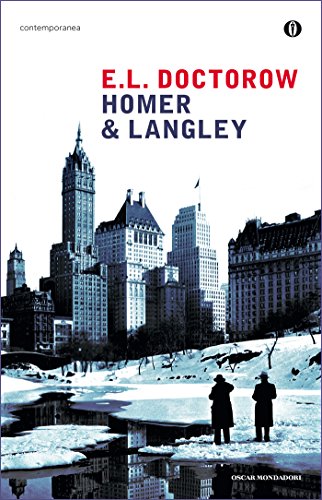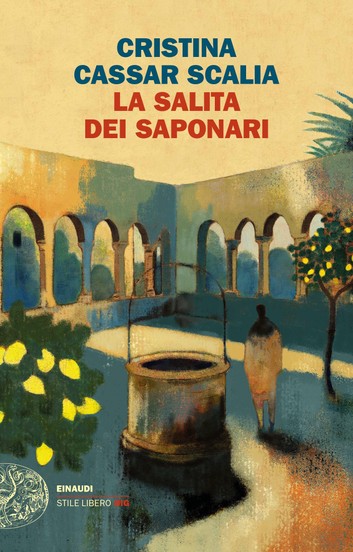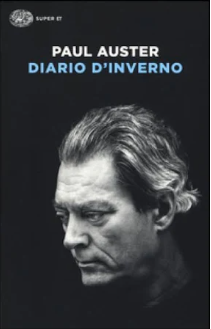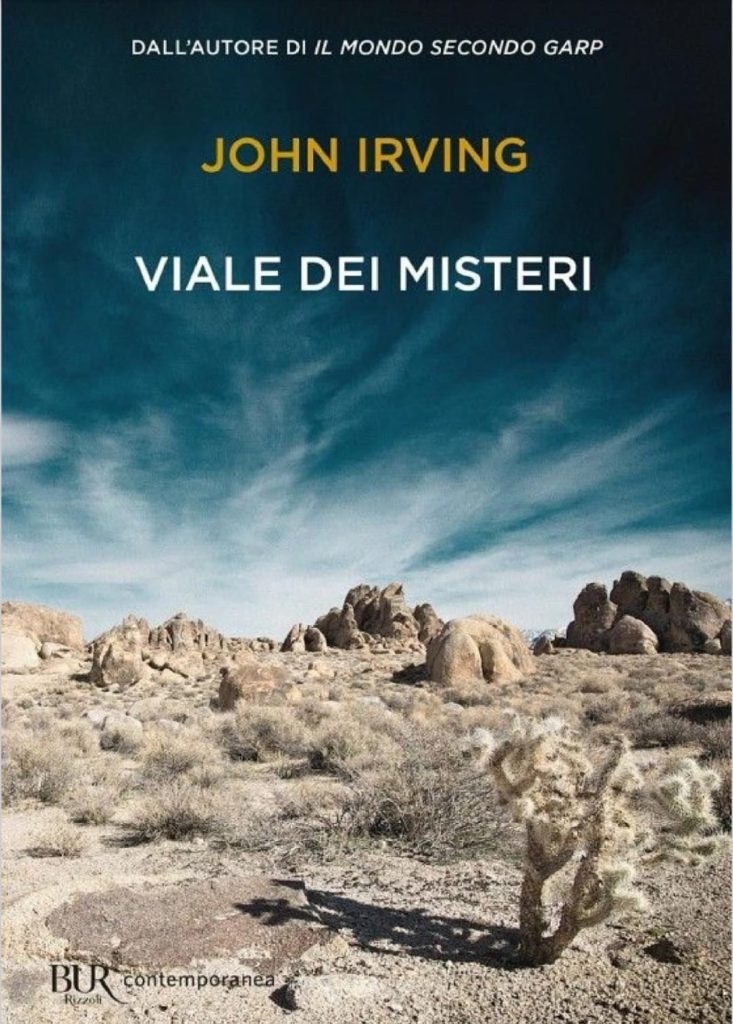È possibile ancora oggi scrivere romanzi per mezzo dei quali restituire, con un misto di storia ed invenzione, la memoria profonda di eventi e personaggi fino a qualche tempo fa esclusi dalla storiografia ufficiale?
Alla risposta, senz’altro positiva, contribuisce l’ultimo romanzo di Ilaria Tuti che con “Fiore di roccia” si allontana dalla narrativa investigativa con cui l’ho conosciuta (“Fiori sopra l’inferno” e “Ninfa dormiente” sono i due romanzi che mi hanno permesso di apprezzarne le doti narrative e di cui consiglio caldamente la lettura) consegnando al suo pubblico un romanzo storico che si legge con passione, con il quale ti conduce sulle montagne friulane, tra le trincee della Prima Guerra Mondiale, conosciuta attraverso lo sguardo compassionevole e il sacrifico di tante donne che per anni sono state dimenticate dalla Grande Storia, ma che con la propria abnegazione e forza di volontà quella Storia hanno contribuito a scriverla.
Si tratta delle portatrici carniche che, sfidando i cecchini, trascurando lo sfinimento, dimenticando la fame, non ascoltando la sofferenza fisica, si arrampicavano sui monti portando sulle loro spalle, provate dalla fatica e dalle privazioni, gerle pesantissime con munizioni, medicine, cibo per i giovani soldati schierati nelle trincee, vittime predestinate di una guerra assurda che riduce gli uomini alla barbarie e ne cancella l’umanità:
“Io mangio radici, questi uomini escono da antri bui
per predare altri uomini alla luce di torce.
Sembra che il conflitto abbia riavvolto le ere,
riportando in superficie usi primordiali”.
È la riflessione di Agata, io narrante del romanzo, personaggio indubbiamente inventato, ma ispirato alle tante donne che durante il primo conflitto mondiale non si sono tirate indietro, consapevoli del triste retaggio imposto loro: sacrificarsi per essere apprezzate in un mondo gestito dagli uomini per gli uomini, ma costruito sulla costante fatica delle donne.
Sono le donne a farsi carico del pesante fardello che la guerra ha caricato sulle loro spalle, imponendo loro di sostituire gli uomini nei campi, di accudire gli anziani malati, di difendersi dalle aggressioni fisiche di uomini senza scrupoli. La fatica, però, non priva le donne dalla capacità, tutta muliebre, di prendersi cura degli altri, nello caso specifico dei giovani soldati di cui si sentono madri, sorelle, fidanzate, pronte a venire loro incontro, dimentiche della propria sofferenza.
Il romanzo è nato dal desiderio dell’autrice di ricostruire quella che nella nota conclusiva definisce “un’impresa epica che ha partecipato in modo sostanziale al corso della storia”. Nella ferma convinzione che “le portatrici carniche sono nel cuore dei friulani”.
Per quanto mi riguarda, dopo la lettura di “Fiore di roccia” queste donne coraggiose sono anche nel mio cuore e, sono sicura, occuperanno un posto anche in quello dei lettori.