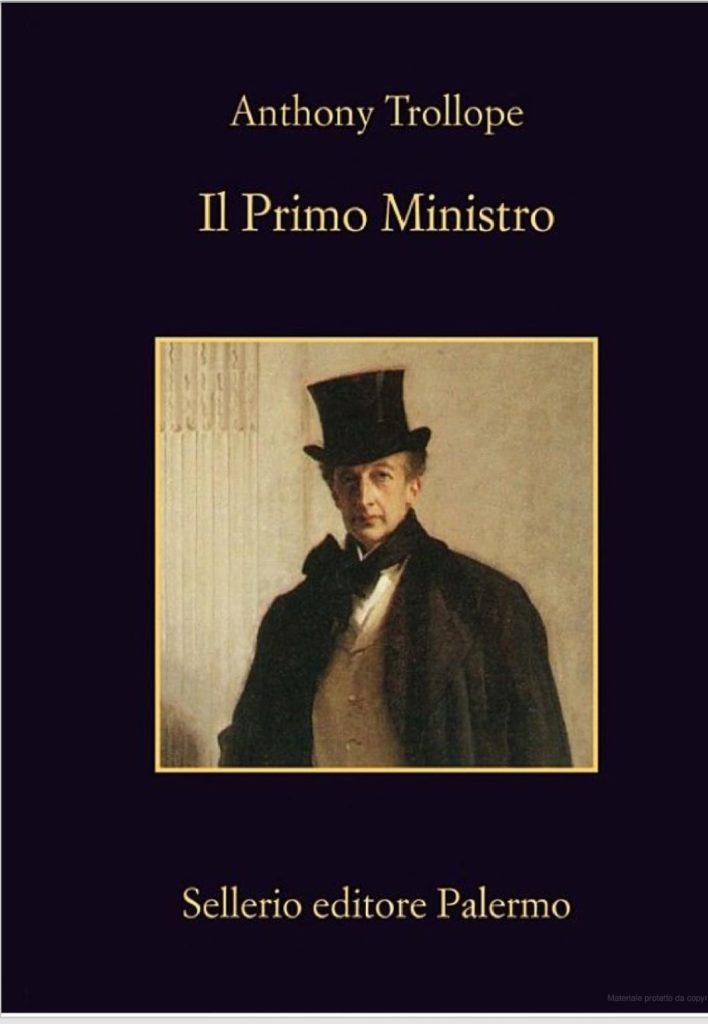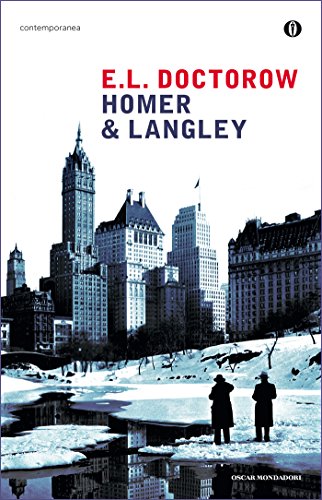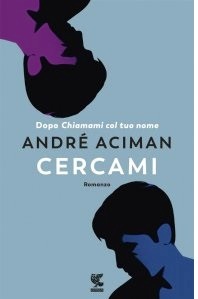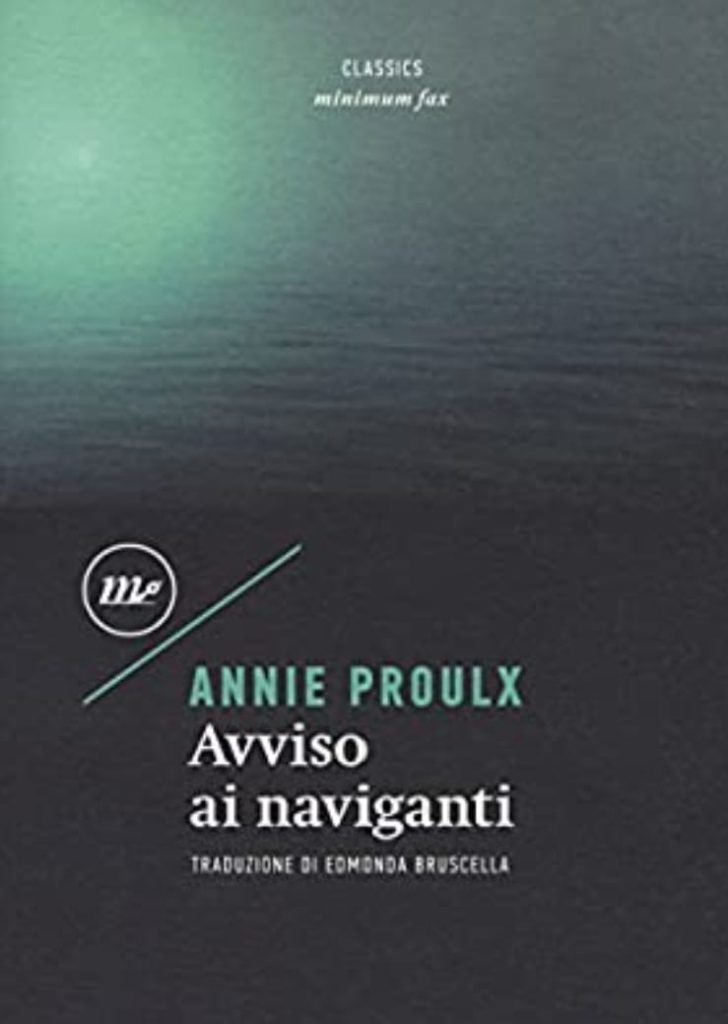
Ho preso in prestito da Ivano Fossati (“Naviganti”) il verso di una sua composizione per condividere con i miei lettori le riflessioni su “Avviso ai naviganti”, romanzo pubblicato nel 1993 con cui Annie Proulx ha vinto il premio Pulitzer e che ho letto come metafora dell’esistere. Una metafora che va ben oltre il semplice accostamento dell’esistenza come viaggio che la letteratura, a iniziare dal mito di Odisseo, ci ha raccontato.
Con una scrittura asciutta, essenziale, a tratti magari distaccata, che non scivola mai nel facile sentimentalismo, Annie Proulx spinge in alto mare Quoyle, giovane uomo inadeguato e impacciato, non amato dai genitori e da fratello, che quasi per caso si ritrova a lavorare per un piccolo giornale dal quale periodicamente viene licenziato e riassunto.
Sempre per casoo, incontra Petal di cui si innamora profondamente e che sposa. La donna, che comunque gli darà due figlie, Banny e Sunshine, non ricambia l’amore sincero di Quoyle che tradisce spudoratamente e liberamente, anche nella stessa casa coniugale, mentre il marito e le figlie dormono al piano di sopra. Fino al giorno in cui scompare da casa con le due figlie, lasciando nella disperazione Quoyle, pronto a perdonarle anche quell’ennesimo tradimento.
Il destino, però, fermerà la fuga d’amore di Petal che morirà in un incidente stradale, dopo avere abbandonato le due bambine che ha venduto per denaro e che Quoyle col coraggio che solo l’amore può dare riesce a liberare.
Dopo la morte dei genitori, Quoyle, al seguito della zia, di cui prima della morte del padre aveva ignorato l’esistenza, lascerà New York per l’isola di Terranova dove inizierà per lui una nuova vita, in una terra dal clima inospitale, ma dove riuscirà a conquistare amicizie, affetti, successo professionale. Dove imparerà, superando ogni paura, a navigare sulle acque difficili che circondano quell’isola, ma anche, per tornare alla metafora iniziale, sulle acque insidiose della vita. Fino a scoprire che nella vita di un uomo può accadere di tutto anche “che l’amore arrivasse senza dolore e senza sofferenza”. Per Quoyle – a cui il lettore impara a volere bene, sentendolo accanto a sé oltre le pagine del libro, grazie alla tenerezza con cui si avvicina agli altri – una conquista che farà propria con lentezza, ma che, senza dubbio, non si lascerà sfuggire.
Annie Proulx fa precedere l’inizio di ogni capitolo dall’immagine e dalla definizione di un nodo marinaresco, presi in prestito da “Il grande libro dei nodi” di Clifford W. Ashley a cui affida anche la citazione, posta in calce alla dedica, che riportiamo lasciando al lettore la libertà di decodificarla, in base alla propria sensibilità ed esperienza personale di navigante al di là del mare:
“In un nodo con otto incroci, un numero che si può ritenere medio, sono possibili 256 combinazioni.
Basta un cambiamento nella sequenza di questi incroci,
e il risultato è un nodo completamente diverso,
oppure il nodo si disfa del tutto”.