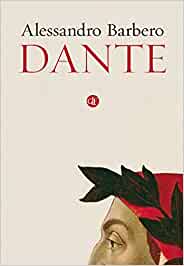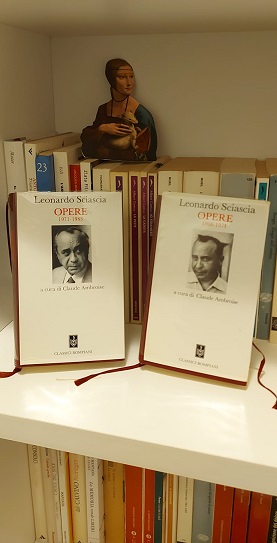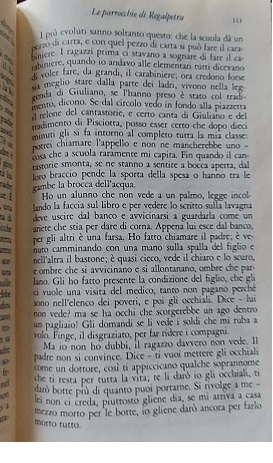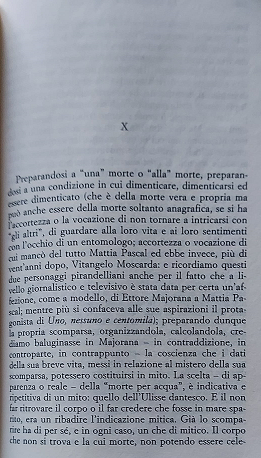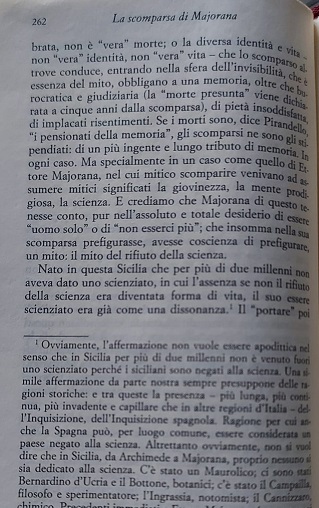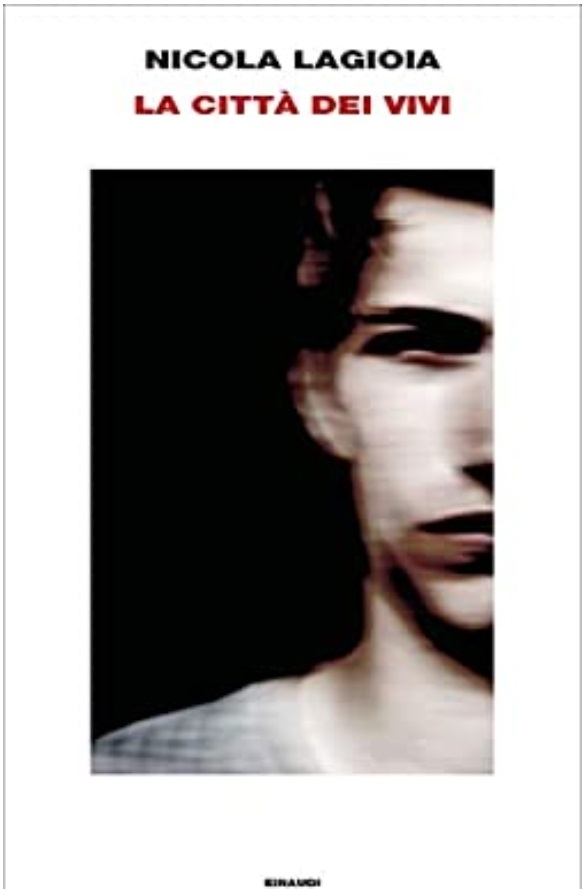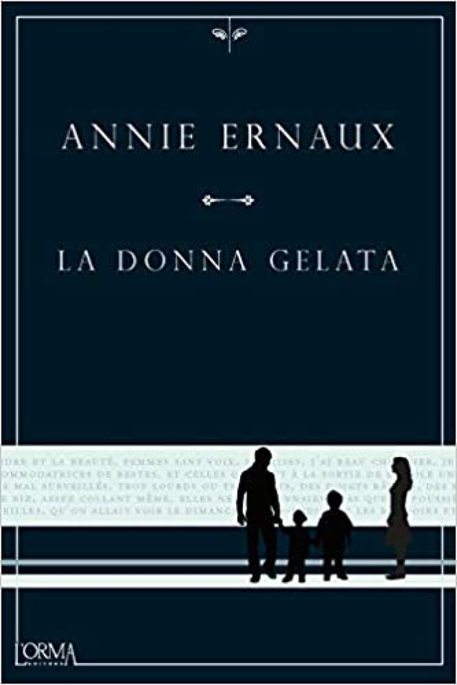
Affermarsi come persona, “come un uomo”, anche senza passare dall’altare; senza lasciarsi condizionare dalle compagne di scuola che vedevano nel matrimonio il traguardo ultimo; ignorando le scelte delle colleghe di Università che studiavano per pura formalità, per snobismo sociale, ma la cui aspirazione era una casa alto borghese e un marito in carriera per godere di luce riflessa: un sogno, per la protagonista de “La donna gelata”, destinato a infrangersi.
Pubblicato nel 1981, ma appena tradotto in Italia, “La donna gelata”, è l’ultimo romanzo di una trilogia autobiografica con il quale Annie Ernaux (classe 1940) completa la narrazione di un percorso esistenziale, dolorosamente vero, vissuto da molte donne del secolo scorso, donne alle quali la società, la famiglia d’origine, un marito egoista e ottuso, hanno tarpato le ali, impedendo loro di affermarsi come persone, di non finire prigioniere di una gabbia, non sempre dorata, in cui la loro esistenza si esauriva nell’essere mogli e madri, nei complimenti ricevuti per la casa, linda e ordinata, per le abilità culinarie, senza mai potere liberamente esprimere se stesse, senza potere progettare il proprio futuro. Anche perché per loro il futuro non esisteva, congelato in una quotidianità sempre uguale a se stessa, nella quale stare in penombra, mettendo al primo posto bisogni di marito e figli.
Un unico capitolo, un racconto in prima persona, dove la voce narrante, quella dell’autrice, ricostruisce l’infanzia della protagonista iniziando dal paesaggio dell’infanzia, nella Normandia del secondo dopo guerra. Figlia unica di una famiglia modesta i cui genitori gestivano un bar drogheria, un microcosmo di uomini e donne grazie al quale ha potuto maturare la consapevolezza di vivere in una famiglia diversa dalle tante di cui sentiva raccontare. Una famiglia dominata da una madre particolarmente forte, capace di lasciarsi andare a scatti di ira violenti, attenta amministratrice delle attività commerciali, una madre che “è la forza e la tempesta, ma anche la bellezza, la curiosità per il mondo, l’apripista sulla strada verso il futuro, che mi dice di non aver mai paura di niente e di nessuno”. Una famiglia in cui la figura paterna non coincideva con quella, al tempo diffusissima, di una padre-padrone, servito e riverito, despota domestico, eroe di guerra la cui parola era legge, violento e irascibile. Un padre, quello della protagonista, che la mattina, mentre gli altri papà erano al lavoro, rimaneva a casa impegnato nei lavori domestici, che giocava con la figlia bambina, che raccontava storie e barzellette divertenti, “una presenza costante, serena e affidabile”.
In questa famiglia (che dal confronto con le compagne di scuola comincerà a considerare anomala, quasi vergognosa) ha preso vita il sogno di potere scegliere della propria vita, liberamente, progettandola come un uomo, immaginando una affermazione professionale, una carriera resa possibile dallo studio rigoroso, nella “convinzione che quasi tutti i guai delle donne siano causati dagli uomini”. Un sogno che sembrava diventare realtà: il trasferimento in città per gli studi universitari, la possibilità di lavorare per non pesare sulla famiglia ed essere indipendente, al punto da potere viaggiare liberamente, anche all’estero (la Ernaux racconta, tra l’altro di un viaggio in Italia). Tutto lascerebbe pensare alla possibilità di un riscatto culturale, di un progetto che potrebbe diventare realtà.
Potrebbe.
Fino a quando la giovane donna libera ed emancipata non è costretta a fare i conti con i modelli che da più parti le vengono indicati, facendola sentire imperfetta e incompiuta. Fino a quando non si innamorerà di un giovane uomo, con il quale condividere la passione per lo studio da cui fare scaturire scelte professionali, possibili per entrambi, immaginando una famiglia diversa in cui essere complementari con uguali diritti e uguali doveri.
Potrebbe, dunque, ma non accadrà.
Forse perché i tempi non erano maturi. Forse perché negli anni Sessanta del secolo scorso non tutti gli uomini erano riusciti a liberarsi da un ruolo legato al sesso, oltre il quale c’era l’ignominia, la vergogna, l’anormalità.
I tempi non erano maturi non solo per gli uomini, ma anche per le donne. Per la protagonista stessa che ad un certo punto scrive:
“mi capitava di pensare
che con un uomo al mio fianco
tutte le mie azioni,
anche le più insignificanti,
caricare la sveglia, preparare la colazione,
avrebbero acquisito sostanza e sapore”.
Il romanzo si colora così delle tinte cupe dell’oppressione, della mancanza di speranza che hanno segnato la storia di tante donne, raccontate,spesso, con dolorosa rassegnazione, ma anche lasciando intravedere la possibilità di un riscatto, di un’alterità, che non può non passare dalla costruzione di sé. Penso ad “Una donna” di Sibilla Aleramo, ma anche a “Dalla parte di lei” di Alba de Céspedes la cui lettura consiglio spesso alle mie studentesse, nella speranza che comprendono il privilegio loro dato e non lo sciupino.