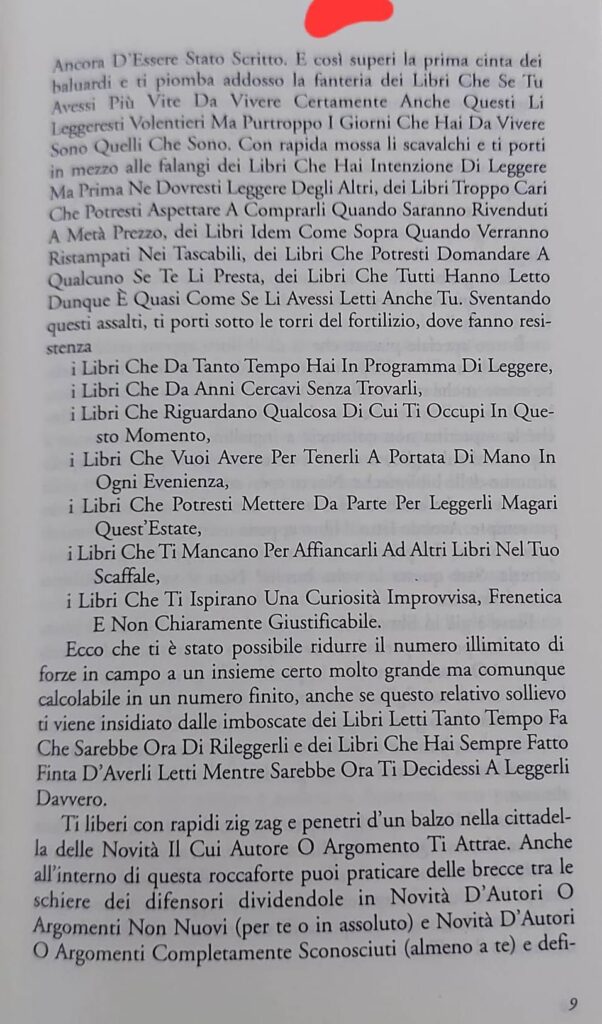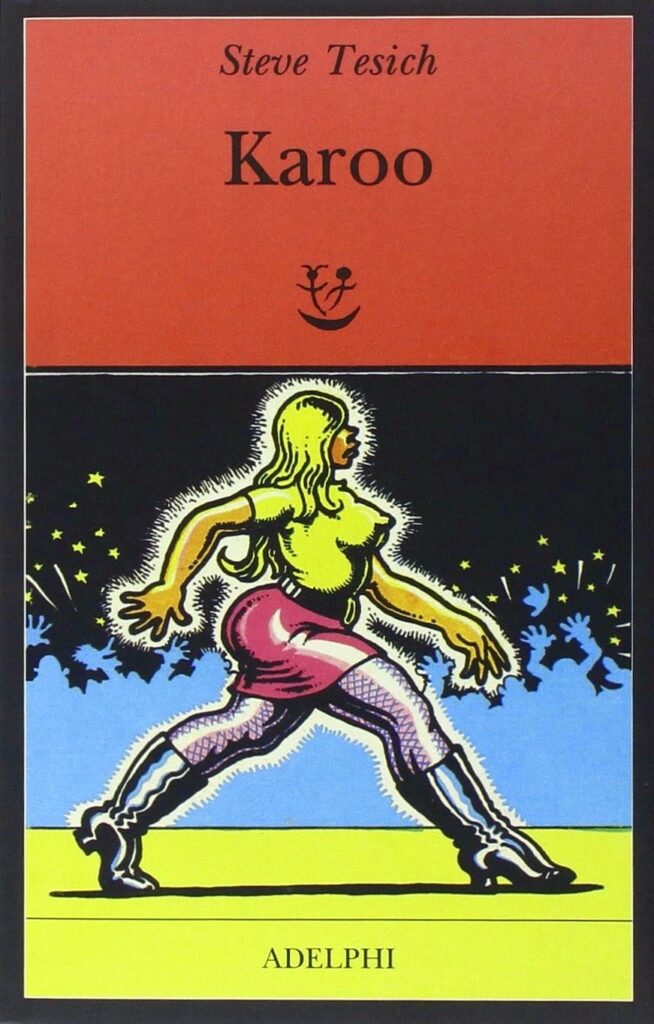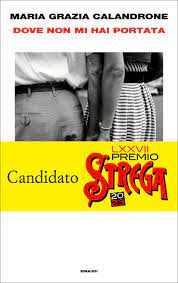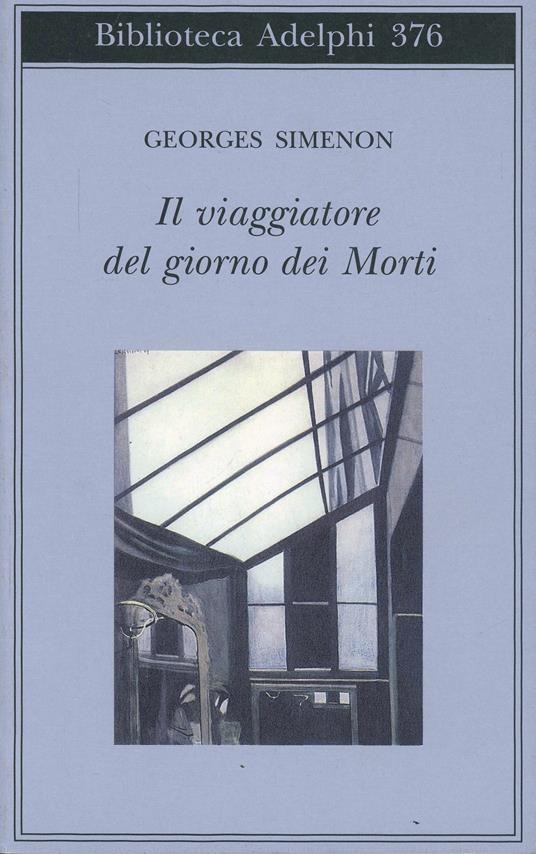Un romanzo di drammatica attualità su un conflitto apparentemente senza soluzione.
È facile, quando si legge o si racconta di guerra, scivolare nella retorica dell’eroismo, del sacrificio consumato per un interesse superiore, a rischio della propria vita. Adania Shibli ne è consapevole e nella prima parte di Un dettaglio minore sembra quasi spingere il lettore verso questa retorica. Lo fa accompagnandolo nel deserto del Negev a conoscere un comandante israeliano le cui giornate si consumano, con ritmo lento, nel monotono ripetersi di azioni sempre uguali. La giornata del protagonista si dipana tra attività di ricognizione nel deserto, al confine con l’Egitto, ordini ai soldati, igiene personale e medicazioni ad una gamba, per una infezione causata dalla puntura di un ragno e trascurata per portare avanti il proprio incarico.
È proprio questo dettaglio che spinge, pericolosamente, il lettore a solidarizzare con il comandante viene visto nella propria umanità, anche più intima. Fino a quando, nel corso di una perlustrazione, non viene individuata una carovana di beduini massacrati insieme ai propri dromedari. Si salva una ragazza, condotta, come prigioniera, nel campo e la cui sorte è tragicamente segnata: il comandante si macchia di un crimine diffusissimo in guerra.
Adania Shibli lo racconta con la pacatezza e il distacco che troviamo nell’intera narrazione, trasformando l’eroe in carnefice, distruggendo ogni retorica edulcorante, mostrando il vero volto della guerra.
I fatti della prima parte del romanzo si svolgono nell’agosto del 1949 (l’anno successivo la guerra arabo israeliana che causò l’espulsione di 700.000 palestinesi) e assumono i colori tragici della contemporaneità nel racconto di una guerra che si ripete ciclicamente, senza soluzione di continuità e che, nei periodi di apparente pacificazione, si impone con posti di blocchi, divieti, restrizioni subite dai palestinesi e documentati da Adania Shibli, nella seconda parte di “Un dettaglio minore”, in un contesto apparentemente diverso. La narrazione, infatti, ci porta nella nostra epoca con protagonista una giovane donna colpita dalla vicenda della ragazza del deserto, portata alla luce da un giornalista assieme ad una fatale coincidenza: la ragazza vittima della violenza di gruppo, venne uccisa e seppellita nel deserto, proprio nel giorno in cui nacque la donna palestinese, esattamente venticinque anni prima.
Così la giovane donna decide di lasciare la propria città , combattere contro la paura fino a superare blocchi militari, geografici, fisici, psicologici e mentali. Blocchi da cui i palestinesi sono schiacciati e ai quali possono ribellarsi solo mettendo a rischio la propria vita.
Il viaggio intrapreso dalla giovane donna palestinese si trasforma in una lenta conferma, l’ennesima, della sistematica e impietosa cancellazione della Palestina:
“di palestinese non è rimasto niente, né i nomi delle città e dei villaggi sui cartelli stradali, né i cartelloni pubblicitari i cui slogan so o tutti scritti in ebraico, neppure gli edifici di nuova costruzione, o perfino i vasti campi che si estendono fino all’orizzonte”.
Pubblicato nel 2021, per la Nave di Teseo, il romanzo ci conduce dentro la desolante quotidianità fatta di sopraffazione, tensione minacciosa, intimidazione e divieti. Una quotidianità estremamente precaria come dimostrano i recenti eventi e la cronaca contemporanea.