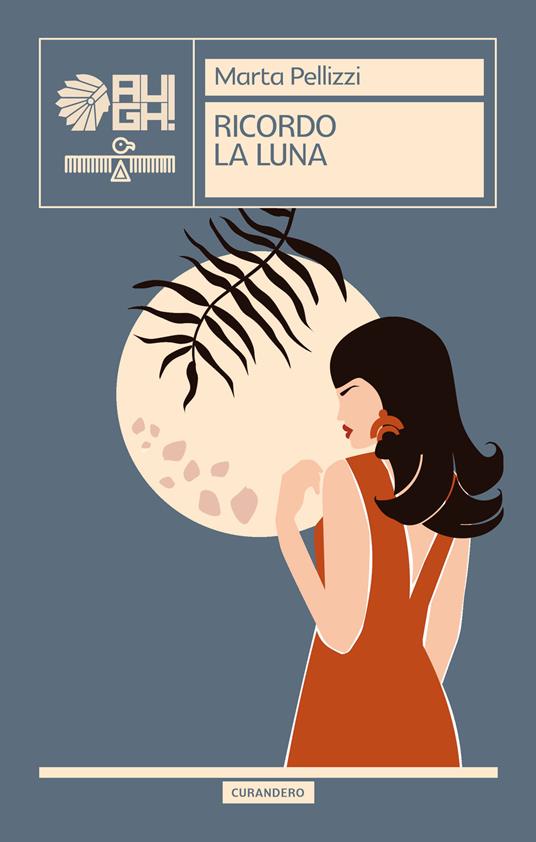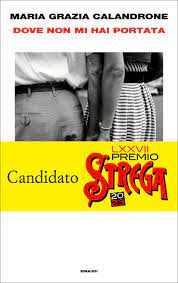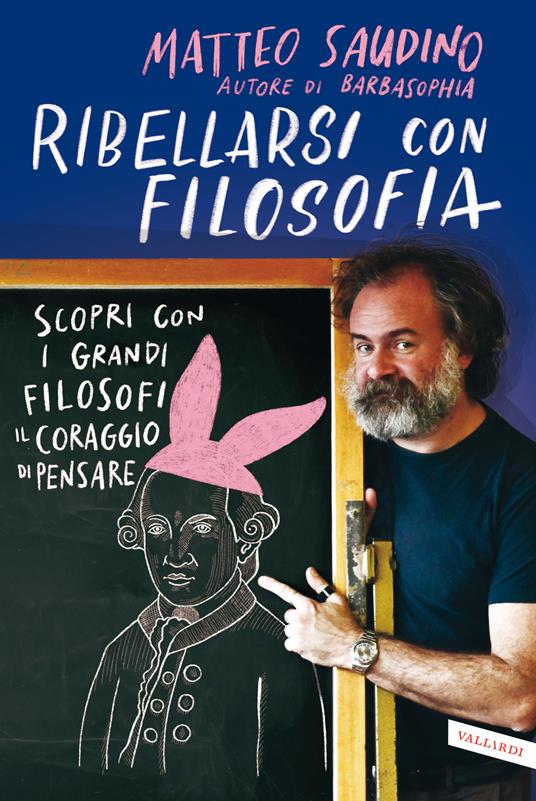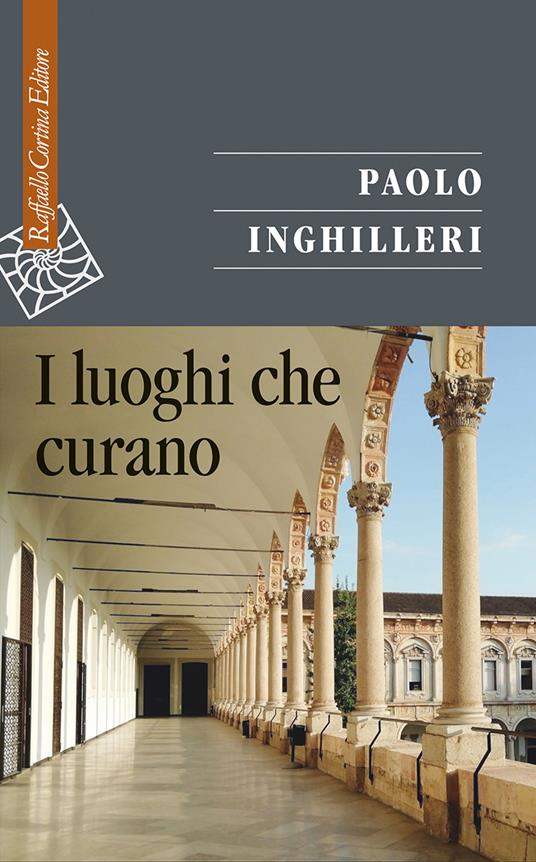“A noi furono risparmiati lutti e deportazioni, ma non lo sgretolarsi della cinquantenaria costruzione del progetto editoriale avviato dal fondatore Leo Samuele Olschki, nonché la diaspora della famiglia e degli affetti” (p.11)

Leo Samuele Olschki aveva lasciato la Prussia orientale, nel 1883 per trasferirsi in Italia e fondare la casa editrice che da lui prende il nome. In pochi decenni grazie alle sue raffinate ed erudite pubblicazioni era riuscito ad ottenere importanti riconoscimenti tanto che Vittore Branca, noto critico letterario all’epoca ancora molto giovane, arrivò a indicarlo come «il favoloso principe dei bibliofili, l’amico di imperatori e di re, dei Morgan e degli Acton, di D’Annunzio e di Rilke». (p. 13)
L’affermazione professionale, conseguenza dei suoi interessi culturali e della passione per la letteratura italiana (e di Dante in particolare al quale dedica un’edizione monumentale della Divina Commedia) non fu sufficiente dopo il luglio 1938. Una data fatidica questa per il nostro paese, perché segna la promulgazione delle legge razziali e l’inizio della persecuzione dei cittadini di religione ebraica. Come Leo Olschki, appunto, che negli anni precedenti aveva già dovuto affrontare attacchi alla propria attività sulla stampa fascista ad opera dei nazionalisti. Il 19 luglio del 1930 su “La tribuna” era stato definito «editore polacco ebreo» reo di “non operare nell’interesse della cultura nazionale” (p. 18). Piccoli segnali che anticipavano quanto sarebbe arrivato in seguito alla pubblicazione del R.D.L. del 7 settembre 1938 con l’ingiunzione a denunciare i collaboratori, gli autori, gli impiegati della casa editrice di religione ebraica. Fu l’inizio: le richieste del “Ministero della cultura popolare diverranno sempre più pressanti fino all’invito ad attivarsi «nel più breve termine di tempo possibile per la sostituzione del nominativo della Vostra Casa Editrice con altro nome ariano» (pag.24)
Ebbe inizio così per la Olschki un lungo e difficile periodo che si protrarrà fin oltre la seconda guerra mondiale e che sarà possibile superare grazie al lavoro e all’impegno degli eredi di Leo. Tra questi vi è Daniele Olschki autore di questo libretto (tale per dimensioni, non certo per il valore storico e per la ricca e preziosa documentazione che ricostruisce la vicenda) il quale per anni ha custodito un fascicolo intitolato: “Meminisse iuvabit” (gioverà ricordare, appunto, oggi più che in passato) dove il nono aveva raccolto il carteggio con il “Ministero della cultura popolare” , fedelmente riprodotto nel libro.