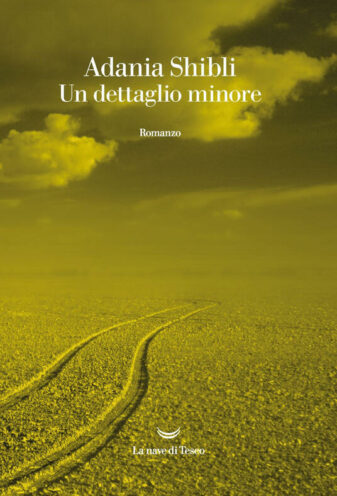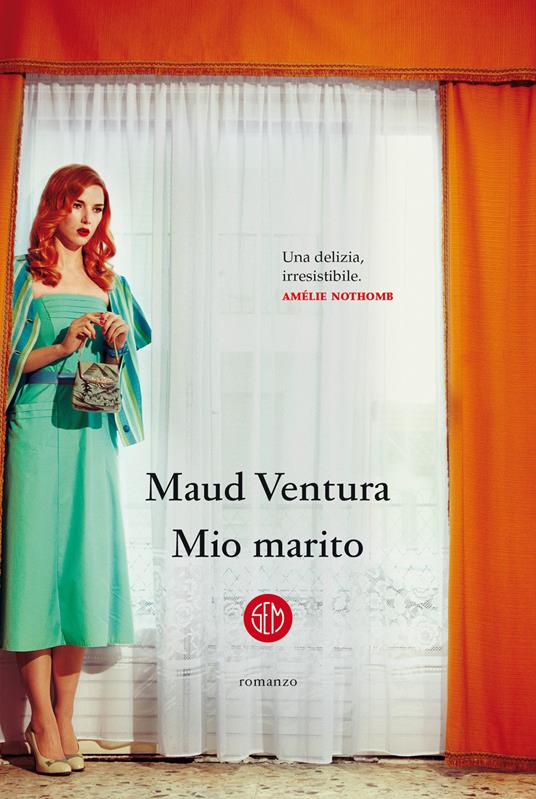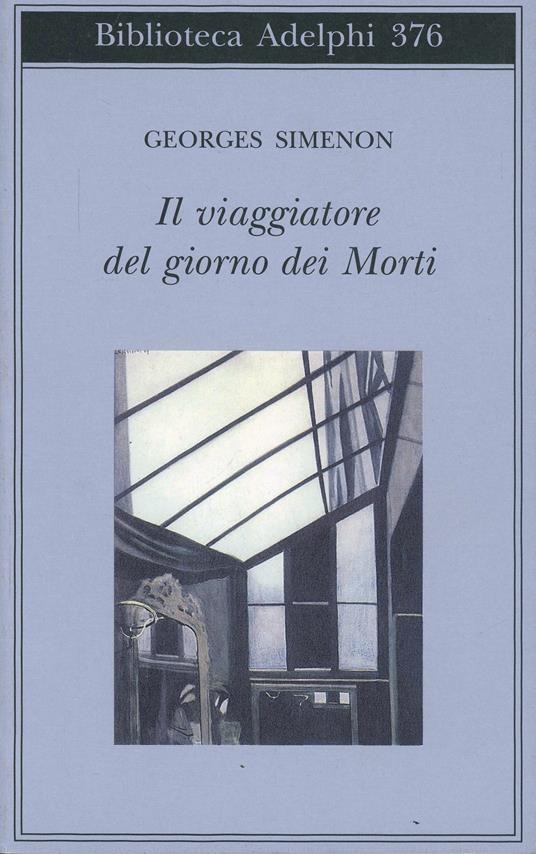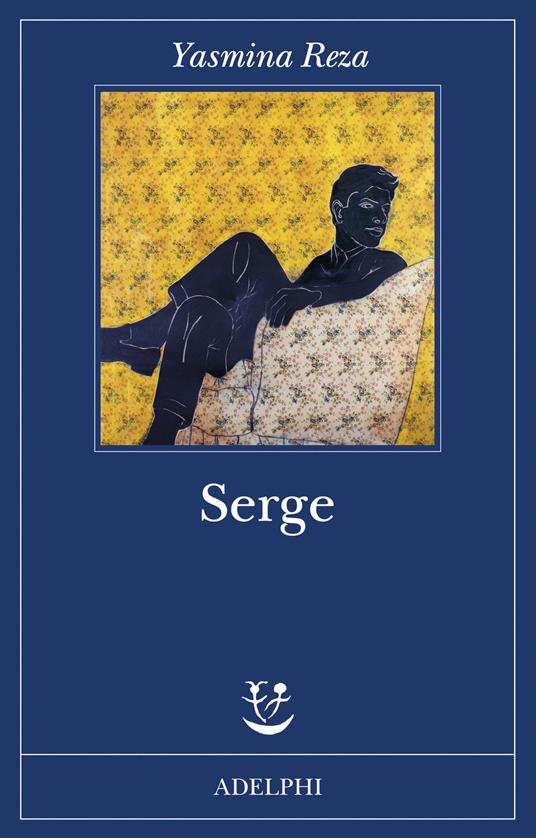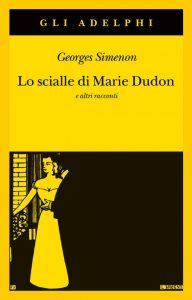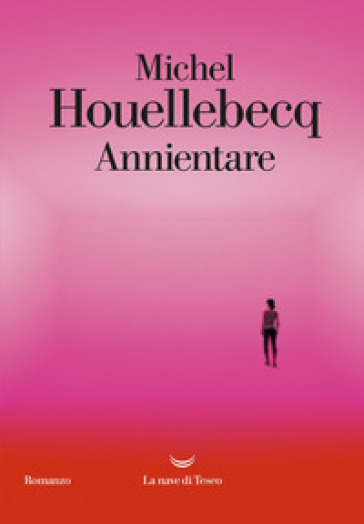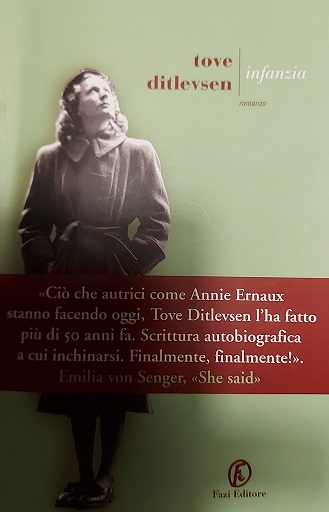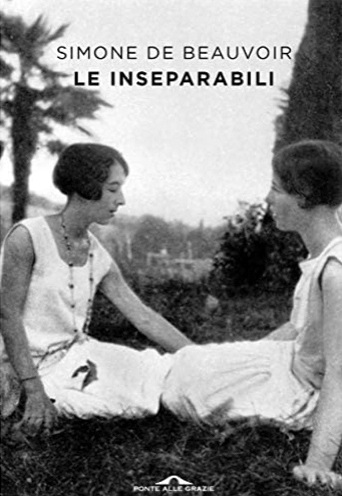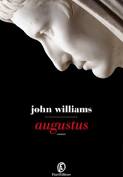“Shūichi voleva indietro l’infanzia, perché essere bambini significava per lui provare esattamente quella paura, disperarsi in quella maniera totale, senza speranza – salvo poi, subito dopo, sorridere e correre a giocare con la ferita che sanguinava ancora”
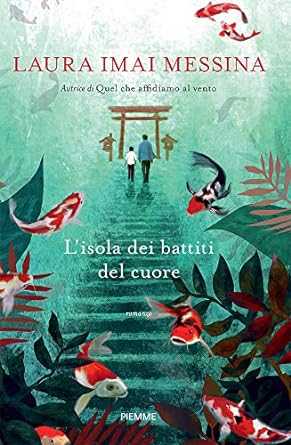
Lo sapevate che il battito del cuore ha tanti suoni quanti sono le lingue del mondo? In basco è bun-bun-bun, ma si trasforma in panp-pnap, se batte nervosamente. In Giappone, dove si svolge la storia al centro del romanzo, un cuore emozionato fa doki doki, ma se è calmo diventa toku toku. In Italia è tu tump. Si potrebbe continuare ancora, ma già questo può bastare per individuare il senso della lunga elencazione che Laura Imai Messina affida al protagonista: tutti abbiamo un cuore, ma ciascuno lo sente in maniera diversa.
Shūichi è, autore di libri per bambini, che disegna e scrive, decide, dopo la morte della madre di lasciare Tokio per trasferirsi nella casa della propria infanzia a Kamakura alla ricerca del sé che sente perduto. Per anni, ha cercato conferme sui ricordi più brutti della propria infanzia, con decisione negati dalla madre e attribuiti al suo estro narrativo, presente fin dalla fanciullezza. Shūichi ha finito con l’arrendersi alle bugie inventate dalla madre per proteggerlo dal dolore, perché convinta che per essere felici bisogna immaginare la felicità.
Purtroppo, però, l’amore di una madre non può essere sufficiente contro i dolori della vita, soprattutto quelli vissuti da adulti. Lo sa bene Shūichi costretto a fare i conti con la memoria del suo passato, lontano e recente, che non gli ha risparmiato sofferenze non solo fisiche. Il ritorno a Kamakura segnerà per Shūichi un nuovo lento inizio, assai diverso da quello che aveva immaginato, grazie a Kenta, un bambino di appena otto anni che gli svelerà molto di sua madre. Ma non solo.
Avrà modo di conoscere Sayaka, incontrata molte volte e subito dimentica, saggia e delicata,capace di mostrare a Shūichi le verità che non riesce a vedere, a condurlo lungo la strada della consapevolezza che il proprio cuore può battere all’unisono con quello di un altro, come in una sinfonia. Fino alla scoperta fatta su “L’isola dei battiti del cuore” dove riuscirà a venire a capo di un piccolo mistero, quasi dimenticato.
Questo di Laura Imai Messina è un romanzo che si legge d’un fiato: la narrazione procede con la levità di una fiaba, ma riesce a scavare dentro l’animo umano, a cercare significati, a comprendere ciò che rimane del nostro passaggio sulla terra. Particolarmente interessanti, poi, si rivelano le spiegazioni di alcuni ideogrammi la cui complessità grafica è il risultato di significati profondi che ciascuna parola porta con sé.