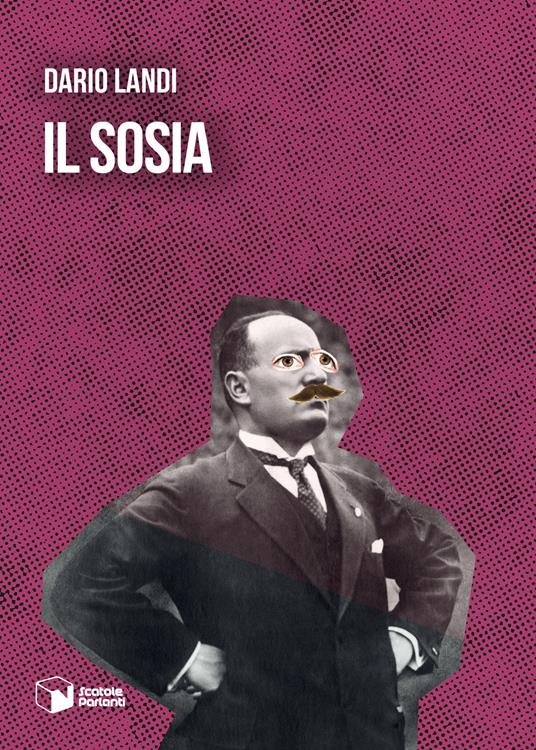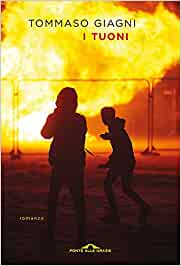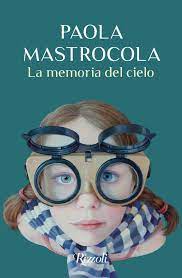
La formazione di molte donne a partire dalla generazione degli anni Cinquanta è avvenuta per sottrazione. Fin da bambine hanno lavorato per evitare di somigliare alle donne loro vicine, per liberarsi dall’iniquità cui quelle donne erano costrette dal ruolo di mogli e madri, percepite come vittime infelici di un padre e marito visto come il carnefice e, in quanto tale, indesiderato e poco amato. Così è stato per Donata, la protagonista de “La memoria del cielo” .
Per tutta l’infanzia Donata ha nutrito e cullato dentro di sé la convinzione, frutto di fantasia, di essere arrivata “dal mondo della luna” per salvare Teresa , di averla scelta come madre “per andarle a dire, nascendo, che non tutto è così malvagio” e per liberarla dalla casa prigione in cui trascorre giornate intere a confezionare abiti per “le signore”.
Ormai adulta, Donata cerca di ricostruire attraverso la memoria gli anni della propria infanzia e adolescenza, provando a mettere ordine ai ricordi, nel tentativo di ricostruire una verità impossibile da trovare perché: “I ricordi dell’infanzia non sono nostri: se nessuno ce li regala, non esistono. Per questo l’infanzia è una colossale menzogna, che raccontiamo prima di tutto a noi stessi”. (pag. 41)
Fin dai primissimi capitoli del romanzo, dunque, sembra che Donata voglia metterci in guardia sul valore da dare al suo racconto e sulla credibilità del suo narrare, fino a svelarci quanto i ricordi possano risultare ingannevoli, perché imprecisi se non addirittura sbagliati:
“Ce li portiamo tutta la vita dentro come se fossero tesori e poi?
Hanno la stessa sostanza della fantasia.
Assomigliano alle storie che c’inventiamo, né più né meno”. (pag. 171)
Donata adulta, quindi, sentirà il bisogno di apprendere il reale svolgimento dei fatti vissuti dalla propria famiglia per conoscere veramente quel padre che aveva sempre rifiutato e condannato perché causa dell’infelicità di Teresa:
“Mi fu chiaro che dovevo difendere mia madre
anche dall’uomo che aveva sposato…” (pag. 80).
Attraverso i ricordi della fanciullezza, per quanto ingannevoli, Donata racconta i cambiamenti dell’Italia del dopoguerra, l’Italia del boom economico reso possibile da quella che chiama “epica del sacrificio”, fondata su un eroismo fatto da rinunce e privazioni che, certamente a lei erano risparmiate (per la bambina c’erano sempre a tavola la carne e il pesce), ma che non accettava. O meglio, la piccola Donata sentiva il bisogno del superfluo, di cui, sostiene “Non è vero che ne possiamo fare a meno”, nella convinzione che “Concedersi le cose inutili è come fare un passo laterale e andarsene per i viottolini di campagna”. (pag. 119) Grazie a quelle rinunce, però, oltre all’appartamento i genitori di Donata poterono acquistare la lavatrice che permise a Teresa di liberarsi fatica del bucato a mano, pur non salvandola dal lavoro di sarta.